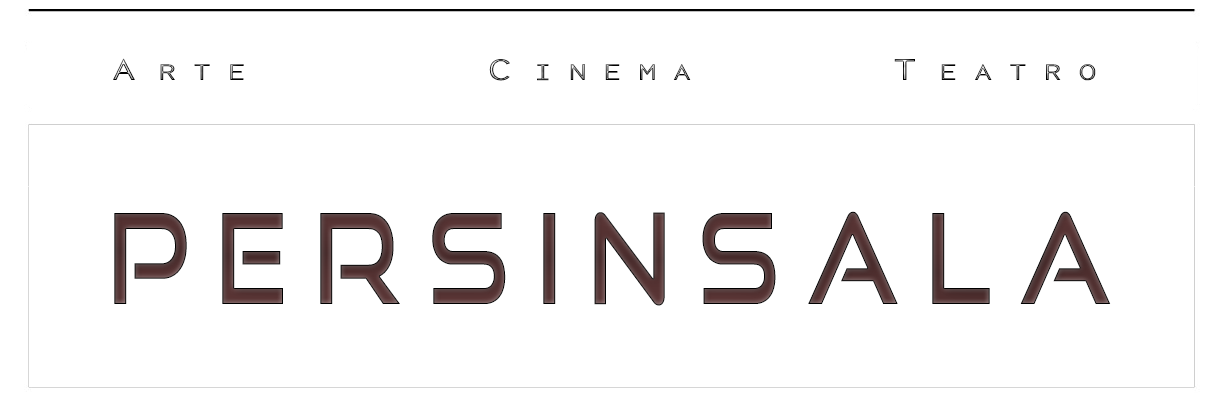La dialettica del “colpo di scena” nell’edizione pandemico-performativa e iperteatralizzata
Il più convenzionale degli eventi della tradizione culturale italiana, sinonimo di gusto nazionalpopolare per eccellenza ed evento di contaminazione reciproca di musica e ambito televisivo e massmediale, si è concluso con diversi colpi di scena, ma senza niente di autenticamente rivoluzionario, come normale che fosse.
D’altronde Sanremo non è nuovo ai “colpi di scena”, e sa bene come orchestrarli e bilanciarli nel corso degli anni: edizione per edizione (come una sorta di sismografo), Sanremo accoglie e assorbe all’interno della propria logica ciò che apparentemente vi si pone esternamente – pensiamo alla dialettica delle “polemiche” funzionali ad alimentare il gusto dell’attesa e la curiosità del pubblico (vai all’articolo del 2020). Il “colpo di scena” non può però essere costante altrimenti la propria funzione di shock ne risulterebbe totalmente compromessa: bisogna calibrarli, alternarli nel corso degli anni, perciò se due anni fa al primo gradino del podio salì Mahmood, l’anno scorso fu l’esaltazione della canonica canzone sanremese di Diodato.
Dicevamo della capacità di Sanremo di assorbire all’interno della propria logica spettacolare persino le forze dialettiche di opposizione, sia a livello “critico” sia a livello “musicale”: da ormai molto tempo Sanremo accoglie e trasfigura nel proprio orizzonte popolare la musica rap – anche nella sua variante “trap” –, la musica folk, la musica dance e la musica elettronica, e ovviamente la canzone d’autore (che è tornata dopo il lungo divorzio avvenuto alla fine degli anni 60). Tutto entra nel cristallo polimorfe di Sanremo e si configura nello specifico calibro linguistico del programma, perché intanto il programma, vale a dire la kermesse, non si rinnova di molto: lo schema del programma, la modalità dello spettacolo televisivo, al di là di qualche marginale variazione, resta lo stesso dopo decine e decine di anni.
Quest’anno però è accaduto qualcosa di diverso, le novità non sono affatto mancate, a partire dalla situazione drammatica, dettata dalla catastrofe in corso, che ha escluso la possibilità di un pubblico in presenza all’Ariston. Ma se questo fattore avrebbe potuto sancire una svolta radicale – per esempio il passaggio all’ambito post-televisivo – in realtà il 71esimo Festival di Sanremo è stato “quasi” un Festival normale, solo senza pubblico.
“Quasi” perché ci sono un paio di elementi che hanno segnato l’edizione di quest’anno, a partire dall’insistenza parossistica per la dimensione performativa e teatrale: per compensare l’assenza del pubblico in presenza, Sanremo ha accelerato sull’impronta più propriamente spettacolare. Dato il livello degli ospiti, il tentativo è stato quello di recuperare l’impatto di fascinazione visiva non solo nelle esagerate performance edonistiche di Achille Lauro, ma anche nella quasi totalità delle esibizioni dei cantanti in gara.
 E poi c’è l’elemento “post-televisivo” che irrompe nello spettacolo televisivo, tendenza molto diffusa nella cultura contemporanea (Sfera Ebbasta che da star del web viene poi assoldato per un programma tv), e a tal proposito veniamo anche al podio.
E poi c’è l’elemento “post-televisivo” che irrompe nello spettacolo televisivo, tendenza molto diffusa nella cultura contemporanea (Sfera Ebbasta che da star del web viene poi assoldato per un programma tv), e a tal proposito veniamo anche al podio.
Quest’anno, il colpo di scena è stato ben orchestrato anche in rapporto ai pronostici espressi dalle classifiche provvisorie: il terzo posto è stato conservato dalla tradizione sanremese classica, un brano e un artista, Ermal Meta, che avrebbero potuto vincere ma “l’anno scorso”, nel momento diverso dell’onda “dialettica”. Questo non era il turno per quella vittoria. D’altronde, per l’edizione di quest’anno, non ci sarebbe potuto essere miglior “nomen omen”: è stata l’edizione del “meta-sanremo”, di un Sanremo sempre nella condizione di giustificarsi dinanzi alla tragedia in corso, un Sanremo che ha parlato di se stesso con conduttori e ospiti che parlavano di loro stessi.
Canzoni che parlavano di musica e di Sanremo, generi che trattavano di generi, artisti che ironizzavano di altri artisti, protagonisti che si sono ritagliati il loro ruolo secondo uno schema assai efficace della popular music, lo schema opposizionale (“io sono diverso da voi”, “io non ascolto quello che ascoltate voi”, “io non sono scemo come voi”). Meta, al di là del nome, non appartiene a questa categoria: elegante, educato, sensibile, l’edizione di quest’anno non era la sua. La spirale dialettica si trovava in una posizione inadeguata, diversamente che nel trionfo del “politicamente corretto” del 2018.
L’oltraggio e l’iconoclastia perciò sono sempre stati presenti a Sanremo, come elemento dialettico accolto nello spettacolo ma mai in condizione di poter vincere: e qui veniamo alla novità, dettata ovviamente dallo strapotere del voto da casa rispetto alla valutazione della giuria demoscopica e dell’orchestra. Il secondo posto finisce al duetto Michelin/marito di Chiara Ferragni, su cui non c’è da aggiungere altro: lo strapotere dei social si riversa nello spettacolo televisivo contaminando uno spettacolo “boomer” e “vintage” come Sanremo.
Nulla di nuovo d’altronde: la “retromania” e il vintage, cifre estetiche ed espressive così come la metatestualità, sono alla base di almeno la metà dei pezzi in gara; col secondo posto di Michelin-Fedez il movimento è opposto, per esempio, a quello di Colapesce-De Martino: non portare gli anni 70-80 nell’oggi, ma portare la contemporaneità (il mondo social) in una cornice vintage (Sanremo).
https://www.youtube.com/watch?v=vfVc-ltT0dk
https://www.youtube.com/watch?v=aJtZj-MK23Y
E questo è vero anche per i vincitori di quest’anno: i Maneskin sono figli della cultura neotelevisiva, provengono da X Factor, un programma certo televisivo ma di una nuova televisione, profondamente dipendente e connessa alla web culture. Però, i Maneskin nel 2017 non vinsero a x Factor, come quest’anno non hanno vinto i Little Pieces of Marmelade, che hanno spostato ulteriormente l’asticella dal “rock” al “noise rock” o quasi al “metal”.
I Maneskin non vincono a X Factor, portano a Sanremo non una “ballata” ma un brano profondamente “rock” e vincono, grazie al voto da casa. Questa è la prima volta non che il rock arrivi a Sanremo, come abbiamo detto, ma che si aggiudichi il primo posto. D’altronde, se pensiamo alla generazione alla quale i Maneskin si rivolgono (i ventenni alle prese con una buona decina di crisi mondiali, con davanti un muro che impedisce la visione di qualsiasi orizzonte) è evidente che la rabbia (così come accade nella trap) diventi il canale privilegiato per stabilire una comunicazione.
https://www.youtube.com/watch?v=1OISmX4vOKA
Ma di che rabbia si tratta? Una rabbia incanalabile e che mostra chiaramente le sue ragioni?Una possibilità di esprimere il disagio per connetterlo alle opportunità redentive e ribellistiche? No, non è affatto questo, lo era molto di più lo straordinario pezzo di Madame, meno didascalico a tal proposito.
https://www.youtube.com/watch?v=HlbisBwxbiw
Zitti e buoni suona come un’accusa ma può essere letto come un imperativo: se come disse Mark Fisher “La morte di Cobain ribadì la sconfitta e l’incorporazione delle ambizioni utopico-prometeiche del rock”, allora che il rock vinca Sanremo e che i rockers piangano davanti alla vittoria è l’ovvio segnale dell’incorporamento del rock stesso nelle logiche dello spettacolo popolare e della rimozione di quell’ultimissimo rimasuglio di potenziale sovversivo che il genere ha avuto nella sua nobile storia. Che pop e rock siano intercambiabili nella logica del consumo postmoderno, a proposito di metatestualità, ce lo hanno cantato proprio gli Stato Sociale in questa edizione.
https://www.youtube.com/watch?v=aRdbIOz1O7E
L’hard rock sfonda i suoi confini e oltre ad approdare a Sanremo lo vince. I prossimi anni potrà essere anche il momento del metal, come i Little Pieces of Marmelade annunciano. E d’altronde, la vittoria dei Maneskin è la vittoria di un rock che non eredita l’esperienza del Punk e del Grunge: non sono i rappresentanti di una classe sociale ed economica che fa saltare, come nella storia dell’hip hop, il meccanismo commerciale ufficiale e istituzionale. Le parole del filosofo Richard Shusterman possono aiutarci a mettere in luce, negativamente, le specificità di questo nuovo rock capace di vincere Sanremo: “Nascendo infatti da oppressive condizioni di schiavitù e di repressione culturale, i complessi livelli di significato (somatico e discorsivo) del rock erano necessari perché esso sembrasse innocuo e razionalmente inattivo, mentre invece esprimeva orgoglio e protesta”.
Quello dei Maneskin è un GucciRock, conciato dal grande Nick Cerioni (stylist anche di Achille Lauro), dipinto e teatralizzato da Givenchy e Gucci. Un rock-ricco, per questo non pericoloso, perché già assorbito dalla dialettica dell’efficacia commerciale dell’apparente tendenza ribellistica e capace di incrementare la forza della classe dominante nel mondo raso al suolo dal virus: d’altronde nelle scuole altolocate di Roma Nord, i professori spesso tentano di far star zitti gli studenti, troppo impegnati nelle loro pratiche tecnomasturbatorie e autocelebrative, fanaticamente egoiche, anche quando appaiono nel segno del glam che si rileva “glam reazionario”.

E se per la trap vale quanto sostiene Slavoj Žižek per cui “l’oppio è l’oppio dei popoli”, per i fenomeni neo-glam, timbrati e definiti dal talento visionario dei fashion designers e dei talentuosi stilisti delle maisons d’alta moda, anche il sesso e l’oltraggio appaiono come l’oppio delle nuove generazioni, che osservano gli schermi (grandi o piccoli che siano) nel loro isolamento pandemico ed esistenziale, trovando in quegli schermi i surrogati inoffensivi del proprio godimento e della propria carica libidinale.