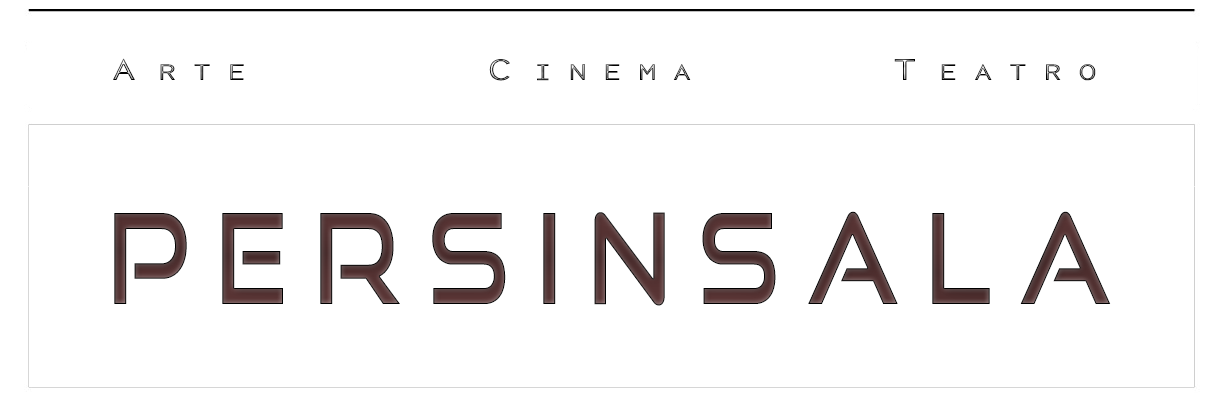Recensione Self-Portrait of a Coffee Pot. William Kentridge si racconta in un originale documentario d’arte da lui stesso diretto. Girato tutto nel suo studio nel 2020, durante il lockdown, Self-Portrait of a Coffee Pot è il ritratto di una personalità prima ancora di un manifesto di poetica.
«Inizi sempre col pensare di dipingere un’immagine dell’universo, ma finisci a disegnare una caffettiera». Da quest’aforistica dichiarazione di poetica e di prammatica prende le mosse Self-Portrait of a Coffee Pot, documentario in tre episodi realizzato su sé stesso dal grande artista sudafricano William Kentridge durante i mesi del lockdown.
William Kentridge è uno degli artisti più originali del contemporaneo, dei più eclettici e indefinibili: i romani ricorderanno la sua magnifica installazione sul Lungotevere, una serie di murales che illustravano la storia di Roma in una successione di episodi dipinti peraltro con l’inchiostro proveniente da una particolare alga marina che ha fatto a poco a poco scomparire i disegni. Kentridge, classe 1955, è un artista che ha sempre dato grande spazio all’effimero, al transeunte, nelle sue opere, ma con questo documentario consegna alla critica e al pubblico un ritratto indelebile della sua personalità, prima ancora che della sua arte.
Self-Portrait as a Coffee Pot contiene esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un documentario autodiretto da Kentridge: autoironia, genialità, opere d’arte atipiche ma magnifiche, riflessioni ad alta voce altrettanto sui generis e altrettanto interessanti. Belle e ben riuscire le animazioni che conferiscono movimento e cinematograficità ai disegni e alle altre opere d’arte che mostra nel corso del documentario. Più volte, contrariamente al dettato di Kant per cui il genio è colui che non può spiegare la propria creatività, assistiamo in diretta al processo creativo di Kentridge, di-spiegato a beneficio della macchina da presa nel momento della realizzazione di diversi dipinti “a muro”. A fare da cerniera tra le diverse parti del documentario c’è peraltro una geniale autointervista a più tempi in cui, invece di uno split-screen, Kentridge riesce ad apparire ad entrambi i lati dell’inquadratura con l’ausilio silenzioso di effetti visivi venuti particolarmente bene – in una scena l’artista arriva addirittura a triplicarsi, spiegando i ricordi personali alla base di alcuni singoli elementi di due suoi disegni, che, sullo sfondo, altri due Kentridge pedissequamente indicano.
A poco a poco, Kentridge ci conduce nel mondo dei suoi personalissimi codici valoriali, routine quotidiane, piccole fissazioni da artista, riflessioni macroscopiche sullo state of art del mondo: nei primi minuti lo seguiamo nel giro del suo studio, che Kentridge stesso definisce «un rituale»; lo sentiamo parlare del suo scherzoso ideale di «procrastinazione attiva» alla base della sua idea di creatività, così come del suo inseguimento di un «pensiero periferico» da applicare all’arte prima ancora che alla vita. In veri e propri flussi di coscienza coram populo, anzi coram camera, Kentridge fa luce su una parte piccolissima dei suoi riferimenti e modelli di ispirazione: da Morandi a Majakovskij, in un totale sincretismo tra le arti, senza mai trascurare un’attenzione continuata ma trasfigurata del quotidiano, delle notizie più spicciole e delle banalità più prosaiche, come l’annuncio della riapertura delle spiagge in Italia dopo il lockdown da Coronavirus, che riporta alla memoria di Kentridge il sapore di un’«ottima torta mangiata a Napoli».
Con Self-Portrait as a Coffee Pot, Kentridge impone un esempio da antologia, anche se forse non replicabile, di art movie, anzi di meta-film sull’arte e su un artista. In passato, dalla fine degli anni novanta fino ai primi anni duemila, Kentridge aveva realizzato diverse sperimentazioni di videoarte e nel 2004 una retrospettiva dei suoi film era stata anche programmata nell’ambito del Festival di Cannes, ma Self-Portrait as a Coffee Pot è, evidentemente, qualcosa di diverso, è un autoritratto che riesce ad essere al contempo una presentazione canonica del lavoro di un artista, comprensibile anche a chi conosce poco o nulla di lui, nonché il prolungamento, stilistico e contenutistico dell’opera di quello stesso artista, in un nuovo medium e registro linguistico quale può essere quello del documentario. Molto interessante e molto in linea con il complesso precedente della sua opera nei suoi tratti più politici, anzi politicizzati, è il passaggio del documentario in cui Kentridge, rievocando episodi e personaggi della sua infanzia, fa luce sul legame che, nel Sudafrica dei tempi dell’apartheid, innegabilmente sussisteva tra il business delle miniere d’oro locali e l’arte, o meglio il mecenatismo artistico da parte degli afrikaner e degli altri imprenditori bianchi impiantatisi più o meno anticamente nella nazione. In questo momento, come in tutto il documentario, Kentridge mostra un’autocoscienza del suo ruolo di artista del tutto inscindibile rispetto alla sua perenne autoironia: anche nel non prendersi troppo sul serio Portrait as a Coffee Pot rappresenta un’ottima lezione, soprattutto se paragonato a un altro, più breve ritratto presentato alla Festa del Cinema di Roma, Aborismi con e su Achille Bonito Oliva, che pure non mancava di aforismi folgoranti.
Titolo: Self-Portrait of a Coffee Pot
Regia: William Kentridge
Fotografia: Duško Marović, Dewauld Aukema
Montaggio: Janus Fouché, Žana Marović, Walter Murch
Produzione: THE OFFICE performing arts + film, Louverture Films
Distribuzione: TBA
Genere: documentario
Durata: 110′
Uscita: TBA