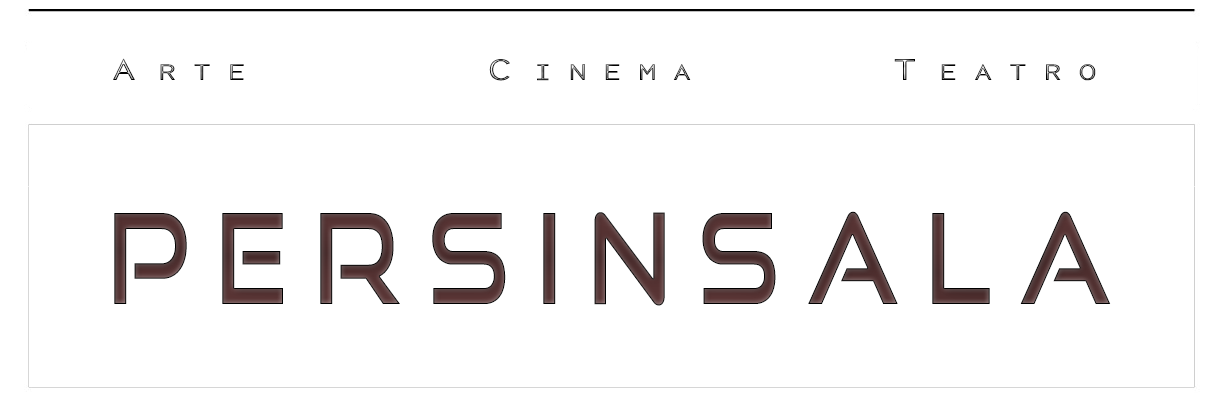La vita dentro

Speranza e rassegnazione sono al centro del recente documentario del regista, autore e produttore Marco Santarelli, in concorso nella sezione Prospettive Italia del Festival Internazionale del Cinema di Roma con Milleunanotte, girato nel penitenziario Dozza di Bologna.
Santarelli segue con la macchina da presa il percorso umano di alcuni detenuti della sezione giudiziaria del carcere bolognese, scandito da lunghissimi iter burocratici. Per questo suo quarto lungometraggio, Santarelli si lascia ispirare dai racconti di Ignazio, monaco e volontario del penitenziario Dozza. L’aspetto umano, infatti, emerge nella narrazione fin dal titolo: mille e una notte è l’inizio di una lettera d’amore di una detenuta che ha trascorso mille e una notti in carcere.
Spesso la difficoltà di girare film in carcere è legata alla mancanza di fiducia dei detenuti verso il regista e a una naturale ritrosia davanti alla macchina da presa. Quale rapporto ha avuto con i detenuti durante le riprese? E i detenuti che atteggiamento hanno tenuto di fronte alla cinepresa?
Marco Santarelli: «Prima di filmare ho aspettato che loro si fidassero di me. Ho ascoltato le loro storie, passato tempo in cella a bere te, caffé, a fumare. Ho passeggiato con loro durante l’ora d’aria, parlando in liberta del più e del meno. Ho rispettato sempre i loro tempi, senza mai forzare le situazioni, trattandoli come persone prima che detenuti. Dopo questa prima fase, ho iniziato a registrare tutti i giorni, ore e ore di materiale, anche quando le cose che uscivano non erano interessanti ai fini del documentario. Mi piace tenere sempre accesa la camera, perchè è un modo per sciogliere le tensione e costruire un rapporto “fisico” con chi ho davanti».
Qual è stato il momento di maggiore soddisfazione durante le riprese di Milleunanotte?
M. S.: «Il momento di maggior soddisfazione durante le riprese di Milleunanotte è stato quando ho deciso di raccontare la storia di Agnes, finita in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. Agnes, l’ho conosciuta pochi giorni prima del suo breve permesso di uscita. Ero partito per filmare storie di vita all’interno del carcere, ma le “circostanze” mi hanno portato altrove. E cosi, quando Agnes ha avuto l’autorizzazione di tornare a casa ho deciso di seguirla. Ecco, questa apertura all’esterno, in cui ho avuto la possibilità di filmare Agnes nella sua quotidianità, è stato tra i momenti più emozionanti della lavorazione del documentario».
E quello di maggiore difficoltà?
M. S.: «Non c’è stato un momento di grande difficoltà, ma tante piccole difficoltà, che ogni giorno ho dovuto affrontare. Confrontarsi con l’organizzazione carceraria e le sue regole non è stato facile. Ma alla fine è andata bene e credo di essere riuscito a realizzare un documentario che affronta aspetti importanti su come funziona la vita all’interno di un penitenziario».
Recentemente la realtà del carcere è stata al centro di Cesare non deve moriredei fratelli Taviani, della sua trasposizione teatrale, e de Il Gemello di Vincenzo Marra, presentato all’ultimo Festival d’Arte Cinematografica di Venezia. Come spiega questo interesse per l’argomento?
M. S.: «Non so. Per quanto mi riguarda, Milleunanotte rientra in un percorso personale di ricerca, incentrato sulle istituzioni italiane e i cittadini che le abitano, da protagonisti, spettatori o che semplicemente le ignorano. Un viaggio cominciato nel 2011 con il documentario Scuolamedia, girato in una scuola di Taranto, e che un anno dopo mi ha portato a Bologna, nel penitenziario Dozza. I miei lavori nascono da microcosmi sociali, all’interno dei quali osservo e indago come le persone vivono, subiscono, si adattano alle regole».
Una domanda provocatoria. Prendendo come riferimento il libro di Truman Capote A sangue freddo, che fece scalpore per l’atteggiamento che l’autore ebbe nei confronti dei criminali, protagonisti di una storia vera, e facendo le dovute differenze – poiché nel suo film non ci sono assassini – non crede che vi sia il rischio per l’autore di un’opera realizzata in carcere di avere un contatto talmente empatico con i detenuti da indulgere sulle ragioni della loro condanna?
M. S.: «Le storie documentate e le situazioni filmate sono state registrate nella sezione giudiziaria del carcere di Bologna, dove si trovano i detenuti in attesa di giudizio e chi deve scontare pene brevi. Si tratta di una sezione difficile, popolata per lo più da reclusi tossicodipendenti e dove spesso chi entra, resta in attesa per mesi, prima di avere una pena definitiva, gli arresti domiciliari o l’assoluzione. Un limbo giudiziario e burocratico, che rappresenta una delle cause principali del sovraffollamento delle carceri italiane. Dentro questo limbo, ho cercato di costruire un percorso di storie che scatenasse emozioni e allo stesso tempo spunti di riflessione sulla condizione umana e sociale di chi finisce in questa sezione. Ho trascorso cinque settimane gomito a gomito con detenuti, volontari e personale carcerario. Un periodo non lungo, ma intenso. Nelle settimane di riprese, mantenere la cosiddetta “barra fissa” sugli obiettivi del documentario non è stato facile, ma non avevo altra strada. Non perdere mai di vista gli obiettivi e le ragioni per cui ero lì, mi ha permesso di contenere gli “istinti di empatia” e costruire una sana e ragionevole distanza da quello che vedevo e raccontavo. Una condizione mentale che mi ha dato la possibilità di cogliere la complessità, delle situazioni e delle storie con cui mi confrontavo. Nel momento in cui si tocca la vita di altre persone, si ha il dovere di essere lucidi e onesti, perché in gioco c’è la fiducia che la persona che hai davanti ti ha donato».
Quale impatto ha avuto su di lei, come uomo e come regista, l’esperienza di girare un documentario in un penitenziario?
M. S.: «Diciamo che quando ho finito le riprese di Milleunanotte, come uomo e come regista, ho riscoperto il piacere di aprire e chiudere una porta da solo».
Quale distribuzione avrà il film?
M. S.: «Per ora Festival in Italia e all’estero, nella speranza di trovare presto una distribuzione».