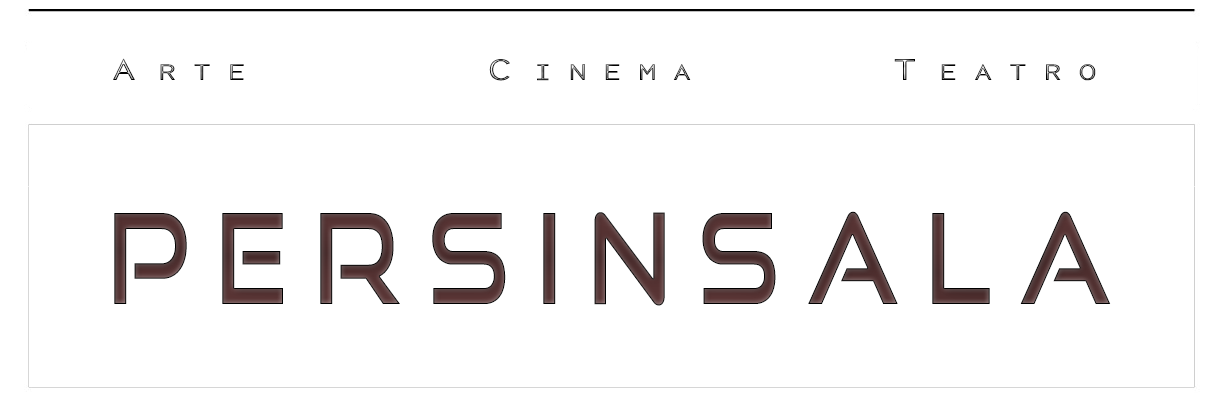Un ritratto a 360° a Rafi Pitts, ospite del Torino Film Festival, dove ha presentato la sua ultima fatica, The Hunter, pellicola che verrà distribuita in Italia dalla Fandango la prossima primavera.
Giovedì 2 dicembre, ore 15.30, Circolo dei lettori di Torino: le segretarie, non avendo a disposizione un programma per il pubblico, non sanno più dove sbattere la testa all’ennesima domanda sugli orari delle conferenze stampa. La fauna umana che girovaga per le sale con aria sperduta – domandandosi chi, cosa, come, quando e soprattutto perché! – appare allucinata e allucinante.
Ma la fortuna è tanta, il Circolo è piccolo e Rafi Pitts è puntuale sulla sua poltrona insieme all’interprete; giusto il tempo di farsi rubare il posto da un simpatico ragazzo che sembra non volersene più andare ed è il nostro turno. Pitts ci accoglie con un sorriso, l’interprete si allontana al cellulare e la lunga intervista ha inizio.
Il regista iraniano, nonostante il jet lag, la conferenza stampa e le numerose interviste precedenti è più che disponibile, si affanna a rispondere con dovizia di particolari a ogni domanda e non tralascia nulla, nemmeno quando gli si chiede l’ultimo film visto: lungo momento di pausa e poi un: «Scusami ma ci devo pensare bene…voglio dirti la verità!» che vale più di qualsiasi altra parola sul personaggio che ci troviamo di fronte.
Quali sono state le maggiori influenze per The Hunter?
Rafi Pitts: «Ci sono così tante influenze… la vera difficoltà nel cinema è riuscire a rimanere se stessi. Certo, ci sono dei riferimenti al cinema americano degli anni 70, a Bogdanovich, Monte Hellman, Cassavetes e Antonioni – per l’importanza data all’architettura del paesaggio. Ma, mentre giravamo il film, non ero consapevole di queste influenze, me ne sono reso conto in sala di montaggio».
La scena in cui, dal tetto, Ali fredda un poliziotto con il fucile – oltre a ciò che la precede – ha molte analogie con una sequenza di Targets di Bogdanovich. Una coincidenza?
R.F.: «No. All’epoca di Targets, Bogdanovich fu influenzato dall’assassinio di Kennedy. Anch’io fui colpito dall’assassinio di Kennedy e mi è piaciuto Targets, ma non credo sia il film migliore di Bogdanovich – a parte la scena della sparatoria sull’autostrada. Quella sequenza e l’assassinio di Kennedy sono la stessa cosa: l’ha detto Bogdanovich stesso. Sono rimasto affascinato dal campo lungo: ha qualcosa di voyeuristico, che alla gente piace molto. In Targets, provi lo stesso piacere del personaggio. Io ho cercato di fare qualcosa di leggermente diverso: ho tolto l’audio. Se non senti nessun suono, ti assale l’ansia, provi disagio. Questa sensazione è quella che voglio suscitare coi campi lunghi».
In Targets c’è una escalation di follia del protagonista Bobby Thompson. Anche la reazione di Ali, dopo la morte della sua famiglia, è dettata dalla pazzia?
R.F.: «Non credo sia pazzo. Lo vedo piuttosto come una bomba a orologeria che sta per esplodere perché non può dar sfogo a ciò che sente. Credo si metta a sparare sull’autostrada perché vive e lavora nei pressi. Il film di Bogdanovich racconta la storia di un ragazzo che perde la testa e uccide la propria famiglia. Il mio è esattamente l’opposto: non è il protagonista a uccidere la propria famiglia, ma è la stessa a essere assassinata. Direi che il paragone tra le due pellicole si limita solo al campo lungo nella sparatoria sull’autostrada. La mia personale ossessione è la sensazione che prova il protagonista sparando al poliziotto con la consapevolezza di stare uccidendo un tutore dell’ordine. Una sorta di interrogativo su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Il mio film mira a sollevare degli interrogativi: posso capire perché il personaggio che ho creato sia spinto a uccidere, ma questo non significa che sia d’accordo con lui».
Più volte, nelle sue interviste, ha dichiarato che il fine del suo lavoro è creare un dibattito – senza schierarsi politicamente. Come procede questo dibattito?
R.F.: «L’ho detto ma ho avuto l’impressione di essere frainteso: dipende da cosa s’intende per politica. Io non appartengo – né apparterrò mai – a un gruppo politico, non credo sia il mio lavoro. Io sono un regista. Però m’interessano gli esseri umani: se questo vuol dire fare politica, allora la faccio. L’Iran è un Paese molto grigio, il mondo intero è grigio. Non credo nella distinzione tra bianco e nero, buoni e cattivi, bene e male. Sono attratto dalle sfumature, da come sono fatte le persone e come diventano ciò che sono. Spesso mi domando ciò che è morale e ciò che non lo è; chi decide cosa è accettabile moralmente e cosa non lo è. Queste, per me, sono autentiche ossessioni. L’Iran è un Paese molto complicato perché il 70 % della popolazione è troppo giovane – al di sotto dei 30 anni – non ha vissuto la rivoluzione, né la guerra tra Iran e Iraq. Il 30% restante, al contrario, ha vissuto entrambi i periodi. Tutte le persone attualmente al governo hanno vissuto la guerra, che è durata otto anni e ha causato un milione di vittime tra gli iraniani. Un conflitto di trincea, non di bombardamenti. Ora, una forte incomprensione – persino ostilità – divide chi detiene il potere dalle nuove generazioni. I miei film cercano di descrivere questa situazione, di farne emergere le contraddizioni. Questo spiega perché, per esempio, i due poliziotti non si vedono di buon occhio».
Ha affermato che lavorare con attori non professionisti le permette di catturare le emozioni autentiche. È stato difficile garantire questo genere di realismo essendo lei stesso il protagonista?
R.F.: «Ho imparato molto dagli attori non professionisti. In The Hunter ero totalmente me stesso perché, se avessi recitato, sarebbe stato immediatamente percepito dal pubblico, vista la spontaneità degli altri interpreti. In questo senso sì, è stato molto difficile, e doloroso anche: non ho nascosto nulla di me stesso. Ero al buio: non potevo contare sulla guida di un regista e, soprattutto, non potevo vedermi mentre recitavo. È stato molto difficile per l’intera troupe. Sono stato costretto a questa scelta da motivi burocratici e, alla fine, mi sentivo lacerato come se fossi il Dottor Jekyll e Mister Hyde».
In The Hunter ha lavorato, per la seconda volta, con Ali Nicksaulat (attore non professionista che, nel precedente It’s Winter, recitava nei panni del protagonista). La ragione di questa scelta?
R.F.: «Perché è un meccanico e adora il suo lavoro (sorride, n.d.g.). Io credo che sia il migliore interprete iraniano – un attore nato, solo che nessuno vuole lavorare con lui. Il suo ruolo in The Hunter è molto diverso da quello in It’s Winter, ma entrambi i personaggi sono piuttosto interessanti. Nella vita reale ripara i motori delle automobili, come il personaggio in It’s winter».
Com’è la situazione della cinematografia in Iran e cosa è cambiato dal 1997 (anno del suo primo lungometraggio, Season Five) a oggi?
R.F.: «Stava andando benissimo fino allo scoppio delle rivolte, ma ora la situazione si è complicata per via della contrapposizione tra il governo e l’industria cinematografica – che si è schierata dalla parte dei dimostranti. Attualmente ci sono molti registi giovani. Nel 1997, quando ho iniziato, la maggior parte dei registi era anziana: appartenevano al periodo precedente alla rivoluzione – come Abbas Kiarostami e Mohsen Makhmalbaf. Adesso, al contrario, c’è una nuova generazione di esordienti. È davvero frustrante che questa situazione si sia venuta a creare proprio in questo momento di grande vitalità».
Un film che tutti dovrebbero vedere.
R.F.: «Ce ne sono moltissimi, ma direi Una moglie, di John Cassavetes. Veramente tutti i suoi film. Oltre a quelli di Antonioni. Poi si può anche morire!».
L’ultimo film visto?
R.F.: «Blood and Wine (Sangue e vino) con Michael Caine: uno dei migliori attori in circolazione, spesso sottovalutato – purtroppo».
Ha fatto notare più volte che in Iran non si girano solo pellicole neorealiste. The Hunter vuole essere una dimostrazione di questo assunto?
R.F.: «Non ho mai avuto bisogno di dimostrare nulla, non è questo lo scopo di un film. Ho fatto quella affermazione perché pensavo che la gente dovesse saperlo. Anche quando ho girato le scene d’azione – come l’inseguimento in auto o la sparatoria – ho applicato le regole del Neorealismo – non le ho girate con un approccio formalista, evidente invece nel primo piano sul poliziotto morente o nell’inquadratura del poliziotto dentro l’auto, durante l’inseguimento. Diciamo che ho fatto un “western neorealista” perché amo il genere western e perché volevo girare un film che fosse in sintonia con le generazioni più giovani, rispecchiando la loro rabbia. Se c’è una cosa, però, che ogni regista dovrebbe fare è correre qualche rischio. I miei autori preferiti – da Antonioni a Cassavetes – non hanno mai temuto di farlo. I film di Michelangelo si assomigliano, ma non sono identici: L’avventura, Professione Reporter, Zabriskie Point non hanno niente in comune eppure la sceneggiatura di base è la medesima. Lo stesso vale per Cassavetes: Una moglie e L’assassinio di un allibratore cinese sono diversi e, nel contempo, la sceneggiatura è similare».
Il Neorealismo italiano con pellicole quali Ladri di biciclette portava in scena un’Italia semidistrutta dalla guerra, in cui attori non professionisti recitavano per necessità, all’esterno degli studi cinematografici, storie di vita quotidiana. Questo genere ha influenzato quello che viene oggi definito Neorealismo iracheno?
R.F.: «Certo, il Neorealismo è nato in Italia, quindi tutte le sue manifestazioni – in Iran, India, Giappone o Cina – sono profondamente influenzate dall’originale. Trovo meraviglioso che la realtà ci insegni cosa fare. La più bella lezione del Neorealismo è proprio questa: il soggetto indica al regista il modo in cui deve essere girato il film».
Il film neorealista italiano per eccellenza?
R.F.: «Sicuramente Roma città aperta: ti lascia senza fiato».
Arrivato al suo quinto lungometraggio (compreso il documentario su Abel Ferrara), c’è un lavoro al quale si sente più legato?
R.F.: «Sarebbe come chiedere a un genitore qual è il figlio preferito…».
L’elemento che lega tutti i suoi film?
R.F.: «Le mie pellicole sono tutte varianti sullo stesso tema: raccontano la storia di persone incapaci di integrarsi nel sistema, che non riescono a farne parte e, per questo, sono perseguitate. Una parte di me si identifica con loro».
Secondo alcuni critici nelle sue opere c’è troppa astrazione nella denuncia del dolore degli iracheni. È d’accordo?
R.F.: «Non credo che i miei film siano astratti ma posso capire perché alcuni critici l’abbiano detto. In realtà, sono molto diretti. Certo, ci sono spunti personali in The Hunter, ma nessuno – nemmeno un iraniano – sarebbe in grado di coglierli. Così come ci sono riferimenti alla politica o al cinema americano, ma non è detto che tutti siano in grado di capirli. Comunque, spero che i miei film possano offrire al pubblico interpretazioni diverse tra le quali scegliere. Un problema grave del cinema contemporaneo – e non mi riferisco soltanto a quello iraniano – è che gli spettatori pretendono di avere una guida con la quale interpretare in maniera univoca una pellicola, e se non la capiscono si sentono frustrati. Al contrario, ogni persona dovrebbe semplicemente fidarsi delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. La verità è intrinseca a ciò che ciascuno di noi sente come individuo, nessuno ha il diritto di dirci cosa è giusto e cosa sbagliato».
Ha mai pensato o pensa che in futuro girerà un film fuori dai confini iraniani (a parte il documentario su Abel Ferrara)?
R.F.: «Ogni pellicola nasce da una mia necessità interiore e in maniera spontanea. Il documentario su Ferrara, ad esempio, si è formato nella mia mente quando Janine Bazar mi ha chiesto di girare un film dedicato a un regista. Citando Frank Capra – che adoro: “Il cinema è come l’eroina, dopo che hai fatto un film, non riesci più a disintossicarti”».
Prima ha citato il Western. Qual è il tipo di Western che le piace e al quale si ispira?
R.F.: «Dipende. Mi piace Sentieri selvaggi di John Ford, C’era una volta il West, e la sparatoria in Le colline blu di Monte Hellman. Trovo il genere così interessante perché questi film affermano il potere della natura sugli uomini, e raccontano della loro lotta per sopravvivere alla follia della natura. In un certo senso, i Western non sono nati negli Stati Uniti, ma derivano da antiche leggende, che non risalgono a due secoli ma a migliaia di anni fa».
un ringraziamento all’interprete, Manuela Gallo