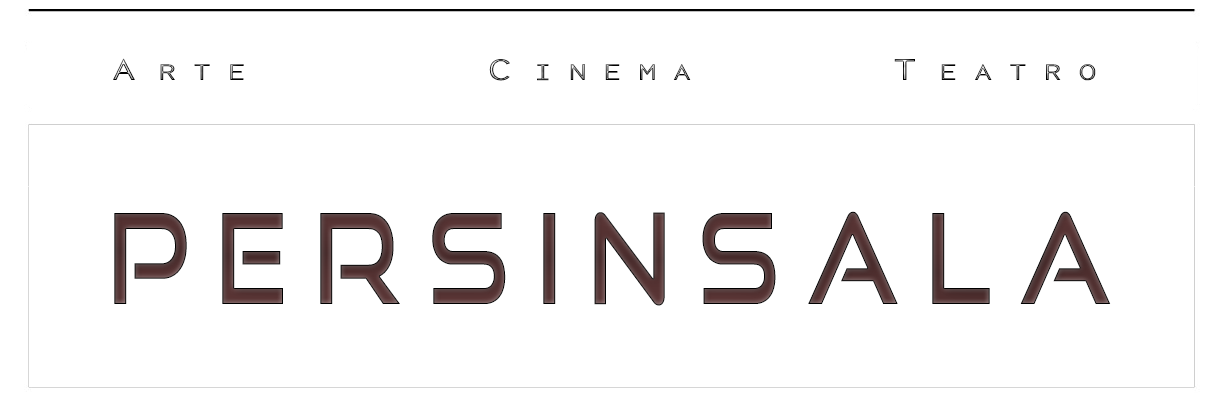Anche quest’anno la Capitale è stata addobbata a Festa e decorata con tante stelle (del cinema) per la quattordicesima edizione dell’evento cinematografico diretto da Antonio Monda, la Festa del Cinema di Roma. E tra selezione ufficiale e sezione parallela portata avanti da Alice nella Città, anche noi di Persinsala abbiamo fatto un giro in Auditorium, e ora vi raccontiamo come è andata.
Anche quest’anno la Capitale è stata addobbata a Festa e decorata con tante stelle (del cinema) per la quattordicesima edizione dell’evento cinematografico diretto da Antonio Monda, la Festa del Cinema di Roma. E tra selezione ufficiale e sezione parallela portata avanti da Alice nella Città, anche noi di Persinsala abbiamo fatto un giro in Auditorium, e ora vi raccontiamo come è andata.
Selezione Ufficiale
Motherless Brooklyn
Il film d’apertura della Festa è tutto all’insegna di Edward Norton. Regista, sceneggiatore, produttore e interprete principale della pellicola, Norton porta sullo schermo un noir (tratto dal libro di Jonathan Lethem) dai toni interessanti, dalle suggestive musiche (il cui tema principale ricorda un po’ Beautiful That Way de La vita è bella, regalandoci un’aria di familiarità decisamente gradita) ma dalla esecuzione forse un po’ troppo scolastica. Tutto o quasi fanno il protagonista, Lionel (un bravissimo Norton) – con le sue peculiarità dovute anche alla sindrome di Tourette da cui è afflitto -, e l’ambientazione, la solenne Brooklyn degli anni ’50.

Per il resto, l’intreccio non possiede davvero quegli agganci necessari a tenere lo spettatore sulle spine, o comunque intrigarlo a tal punto da coinvolgerlo nella risoluzione del caso. Più dedito ai suoi personaggi che all’azione – anche se, davvero, a risaltare alla fine sono più Norton e Willis, nonostante la precoce dipartita di Frank (Willis), rispetto ad altri con maggiore screen time, eccetto forse la Laura Rose della promettente Gugu-Mbata Raw -, Motherless Brooklyn apre la Festa probabilmente con meno forza dei due film inaugurali precedenti (Hostiles e Sette sconosciuti a El Royale), ma ci fa dono comunque di grandi momenti… “If!”.
Downton Abbey
La Famiglia Crawley vi attende per cena.
L’Auditorium Parco della Musica, per un giorno, si è trasformato nell’Inghilterra del ventesimo secolo, e il pubblico è stato trasportato nelle atmosfere dello Yorkshire assieme ai residenti di Downton e… Alla famiglia reale!
Il lungometraggio conclusivo (anche se si parla già di sequel) della serie tv creata da Julian Fellowes e durata 6 stagioni, Downton Abbey, ha visto Lord e Lady Grantham (Hugh Bonneville e Elizabeth McGovern) ricevere l’inaspettata (ma annunciata in una suggestiva sequenza iniziale che riprendeva proprio il pilot dello show) visita del Re e della Regina d’Inghilterra e, ovviamente, tutta la residenza si adopera per prepararsi al meglio ad accoglierli.

Vecchi e nuovi volti hanno popolato lo schermo, da Lady Mary (Michelle Dockery) alla Principessa Mary (Kate Phillips); dall’immancabile Lady Violet (Maggie Smith, a cui come sempre sono state affidate le migliori battute) alla new entry interpretata da Imelda Staunton, Maud Bagshaw; dal socialista Irlandese Tom Branson (Allen Leech) al maggiordomo dei reali Richard Ellis (Max Brown), i fan di lunga data – ma anche chi non ha mai visto la serie – hanno potuto (ri)trovare dei personaggi ben delineati, e afferrabili persino con uno screen time ridotto rispetto a quello televisivo. Leggero, ma non superficiale, divertente, ma non privo di forza drammatica, il film di Downton Abbey ha fatto il suo lavoro, offrendo agli appassionati dello show un nuovo capitolo nelle avventure dei loro personaggi preferiti, e allo spettatore occasionale due ore di sano intrattenimento.
Honey Boy
Il racconto autobiografico romanzato di Shia LaBoeuf, sceneggiatore e interprete della pellicola (anche se non nel ruolo di sé stesso, bensì in quello di suo padre) diretta da Alma Har’el, Honey Boy, ha scaldato i cuori del pubblico della Festa. Un emozionante quanto complicato excursus nella vita di Otis, un giovane attore interpretato, nei diversi momenti della sua crescita, da un eccezionale Noah Jupe e dal Lucas Hedges di Boy Erased e Ben is Back, che fa comprendere come una carriera che tanto può dare, possa anche togliere più di quanto si possa immaginare.

Ma non è tanto questa ad essere al centro del tutto, quanto le relazioni, le dinamiche (e le influenze derivate dall’idea di una vita fatta di successi) tra gli esseri umani portati sullo schermo. Primo fra tutti il difficile rapporto padre-figlio tra Otis e il padre James, che andrà a scolpire inevitabilmente il futuro del ragazzo, e che una volta adulto, dovrà fare i conti con il suo passato e trovare una forma di catarsi per poter andare finalmente avanti. Cinema, televisione, sogni e illusioni, delusioni e piccole e grandi battaglie quotidiane costellano Honey Boy, brutalmente onesto, ma ancora ricco di speranza.
Hustlers
Jennifer Lopez torna a incantare sullo schermo con la sua Ramona Vega, uno dei personaggi principali di Hustlers, o come lo abbiamo chiamato in terra nostrana, Le ragazze di Wall Street – Business is Business. La pellicola scritta e diretta da Lorene Scafaria e acclamata criticamente fin dal suo debutto al Toronto Film Festival si ispira a un articolo scritto da Jessica Pressler per il New York Times, The Hustlers at Scores. Vivace, disinibito, ma non per questo volgare, e con un punto di vista sufficientemente innovativo, Hustlers mette in risalto l’umanità, la realtà dietro un mondo che potrebbe sembrare così distante da quello quotidiano, ma che altro non è che quotidianità per le ragazze protagoniste. I personaggi interpretati da Constance Wu, Lili Reinhart, Keke Palmer (ma non solo), guidati dalla figura di Ramona (Lopez), si fanno strada in un mondo difficile, che non perdona chi non riesce ad adattarsi, ma che non fa sconti a chi ci prova e poi viene “beccato” (anzi, beccatA).

Esposte mediante l’espediente della narrazione a terzi, la giornalista interpretata da Julia Stiles, le vicende prendono forma nel racconto di Destiny (Wu), ma riflettono una prospettiva molto più ampia, che non terrà alla larga né la sua interlocutrice, né lo spettatore, che si troverà a empatizzare con le ragazze, pur comprendedo la gravità delle loro azioni. Ottima prova per la Scafaria, e probabile contendente agli Oscar in più di una categoria, Hustlers saprà farsi guardare, e non solo per le ragioni che potrebbero sembrare più ovvie.
The Irishman
Adattamento cinematografico di un saggio di Charles Brandt, I Heard You Paint Houses (L’Irlandese. Ho Ucciso Jimmy Hoffa), The Irishman di Martin Scorsese si fa summa del cinema del regista di New York, con le sue 3 ore 29 minuti di durata (che, forse, di qualche piccolo taglietto avrebbe anche giovato), ma che mostra nella maniera più chiara la poetica e gli intenti del suo autore. Con degli strepitosi De Niro, Al Pacino e Joe Pesci (quest’ultimo ci regala una delle sue migliori performance) e con l’aiuto della tanto chiacchierata tecnologia di de-aging (e dei finanziamenti di Netflix), Scorsese ci racconta la storia di Frank Sheeran (De Niro), l’Irlandese del titolo, un veterano della seconda guerra mondiale divenuto sicario della mafia, che stringe amicizia con il boss Russell Bufalino (Pesci) e il noto sindacalista Jimmy Hoffa (Pacino), il quale perirà proprio per mano del primo.

In un andirivieni di momenti passati e presenti, si dipanano le vicende che hanno segnato l’esistenza di Frank, tra amicizie, alleanze, fedeltà e tradimenti, corredate dalla violenza e dalle perdite che tali scelte si portando dietro. Ma se ci si dilunga fin troppo in alcune istanze, dissipando forse quel vigore che invece presenta in apertura, e ancor più in chiusura, il punto è proprio quello di voler prendere tempo, di volerSI prendere del tempo, per lasciare che tutto accada ancora una volta, nella sua inesorabilità. Sta poi allo spettatore giudicare se è tempo ben speso.
Judy
I problemi, i dolori, le difficoltà, di una delle più celebri star della vecchia Hollywood condensate in un biopic che si concentra sull’ultima fase della carriera e della vita di Judy Garland, e che mediante flashback onirici ce ne spiega le radici, le origini. Rupert Goold, però, non permette all’oscurità di accecare completamente il bagliore della Garland, e ci mostra anche alcuni tra i suoi momenti più felici, seppur incorniciati da un contesto non proprio spensierato, come le scorribande con i personaggi interpretati da Andy Nyman e Daniel Cerquiera, o un’ultima, commovente esibizione sui palchi di Londra.

Judy è tutto (o quasi) Renée Zellweger, che oscillando tra la grande interpretazione e una versione quasi macchiettistica dell’attrice e cantante, porta sulle spalle il peso di un film, e di una vita, all’insegna dell’arte e delle emozioni, come della ricerca della felicità, lì, oltre quell’arcobaleno di cui abbiamo sentito tutti parlare (e cantare).
Scary Stories To Tell In The Dark
Leggero e familiare, Scary Stories To Tell In The Dark si affida ai racconti metropolitani, quelle urban legend dell’orrore riportate anche nei libri da cui trae ispirazione, per unirsi al filone Piccoli Brividi, senza però accostarvisi troppo. Una serie di macabri episodi legati tra loro da un libro e una casa, neanche a dirlo, infestata, movimentano la piccola città fittizia di Mill Valley, in Pennsylvania, tra piccoli jump scare (ma non troppi) e spunti di riflessione sociali e politici, e mantenendo costante l’attenzione dello spettatore.

Nulla di imprescindibile, nulla di estremamente innovativo, ma la pellicola diretta da André Øvredal e prodotta da Guillermo Del Toro trasferisce sullo schermo l’accessibilità dei racconti di Alvin Schwartz e li adatta a un pubblico altrettanto variegato, che uscirà dalla sala forse non incredibilmente entusiasta, ma almeno sommariamente soddisfatto dalla visione (e terrorizzato all’idea di ritrovarsi un foruncolo più grande del normale sul viso).
The Vast Of Night
Racconto paranormale dal sapore di The Twilight Zone, a cui è riservato l’omaggio, soprattutto in apertura, con la meta-narrazione seriale sul piccolo schermo televisivo, su cui va in onda un episodio di Paradox Theater, The Vast Of Night è un tentativo (non esattamente riuscito) di dare allo sci-fi uno stile autoriale, pur mantenendosi in campo mainstream. Ma perché abbiamo inserito quella parentesi?

Perché seppur stilisticamente parlando sia decisamente notevole, il film di Andrew Patterson si perde a livello contenutistico, andando avanti a forza di dialoghi non troppo convincenti (non tutti hanno la capacità innata di un Joss Whedon di rendere pertinente e fondamentale ogni parola pronunciata dai propri personaggi) e atmosfere adattissime, aiutate anche da una suggestiva e decisamente conveniente ambientazione, ma che da sole non possono certo tenere in piedi l’intera operazione. Più sostanza e meno manierismi formali avrebbero probabilmente aiutato l’esperimento di The Vast Of Night a emergere vittorioso e ad ergersi come capostipite di una new wave del genere.
Alice nella Città
Playmobil: The Movie
Un Lego Movie Wannabe, che di Lego Movie ha molto poco… Purtroppo. Playmobil: The Movie, il film ibrido tra live-action e animazione diretto da Lino Disalvo, e ispirato dai celebri giocattoli ormai in circolazione da circa 45 anni, ha sfortunatamente poco da spartire con la fortunata saga di simile struttura, ma di fattura decisamente superiore. Certo il budget e i mezzi a disposizioni sono diversi, ma anche a prescindere da ciò, nonostante venga spontaneo una sorta di paragone tra le due operazioni, a livello narrativo e soprattutto in fatto di dialoghi, Playmobil non si avvicina neanche lontanamente al più illustre collega.

A giocare maggiormente a sfavore del film con Anya-Taylor Joy e Gabriel Bateman è la palese intenzione di volersi rivolgere a un pubblico giovanissimo, ma senza tenere in conto che anche i più piccoli possano apprezzare di non essere trattati come tali. Non c’è bisogno di semplificare eccessivamente, a rischio di rendere sciocchi e ridicoli, gli elementi in gioco. Non c’è bisogno di scadere nel banale con i brani e le battute dei personaggi, così come con il loro sviluppo. E non c’è bisogno di sovraccaricare di “buone intenzioni e sentimenti” la storia, solo perché indirizzata a un’audience più “influenzabile”.
Detto questo, ci sono state delle trovate degne di nota, come il personaggio di Rex Dasher, e la scelta di Cristina D’Avena come doppiatrice della Fata Madrina. Ma qualcosa ci dice che in originale avremmo potuto apprezzare maggiormente il tutto.
Light Of My Life
Casey Affleck in tripla veste per Light of My Life, una sorta di distopia in una realtà in cui le donne sono state colpite da un virus che le ha eliminate quasi tutte, portando le poche rimaste a doversi nascondere per difendersi e sopravvivere al duro ambiente che ormai le circonda. Affleck, regista, sceneggiatore e interprete di uno dei due protagonisti della pellicola, è il padre di Anna (Anna Pnyowski), una ragazzina di undici anni che si finge dell’altro sesso e che vive alla giornata – in costante fuga e timore di essere scoperta – assieme all’unico genitore che le è rimasto.

I due, in un toccante viaggio più all’insegna della sopravvivenza e del proteggere l’un l’altro, che di una specifica meta, cercano a tutti i costi di andare avanti un mondo che sembra aver dimenticato la gentilezza, il rispetto per la libertà altrui e l’amore per il prossimo. Nella seconda prova di Affleck in cabina di regia dopo I’m Still Here, l’attore Premio Oscar per la miglior interpretazione maschile in Manchester By The Sea porta sullo schermo un racconto ben girato, anche se forse un po’ lento nel procedere, ma che si guarda con attenzione e preoccupazione per le sorti dei personaggi. Di grande impatto le ambientazioni, soprattutto nella fase iniziale della pellicola, con la vastità dei boschi in cui trovano rifugio, come anche in fase conclusiva il paesaggio innevato che senza alcuna clemenza li costringe a procedere in condizioni estreme nel loro viaggio. Buona anche la seconda, dunque, per Casey Affleck. E, si spera, non l’ultima.